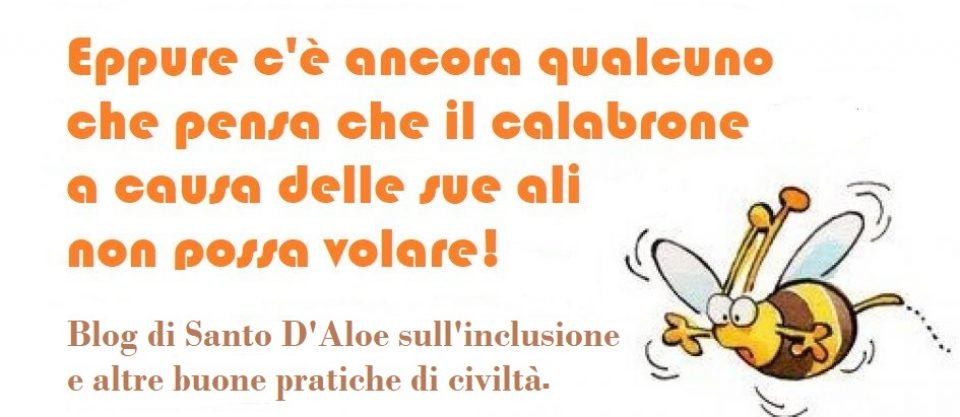Tag
Assistenza igienico-personale, CCNL Scuola, Collaboratori scolastici, D. Lgs. 66/2017, Inclusione scolastica, Personale ATA

Cambiamenti lenti ma importanti sono nella scuola in atto nella didattica della disabilità. Le direttive sembrano sempre più muoversi verso un criterio d’inclusività per cui l’intera scuola deve agire come una “comunità” accogliete e collaborante dove tutti, dal dirigente ai docenti al personale ATA, e col supporto degli studenti, delle famiglie, dei servizi sanitari e degli enti locali, diventano agenti dei processi strutturali, organizzativi, metodologici, didattici e culturali.
L’obiettivo di una scuola nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare positive esperienze di crescita individuale e sociale viene perseguito attraverso una più ampia e collaborativa progettualità che tende a valorizzare tutte le professionalità interne alla scuola, oltre che importanti risorse offerte dal territorio.
Proprio in quest’ottica l’ultimo contratto di categoria e le più recenti normative hanno attribuito al personale ATA e ai collaboratori scolastici in particolare un ruolo più preciso nel processo didattico e d’inclusione. Importanti novità in questo senso sono introdotte dal comma 3 dell’articolo 41 dell’ultimo contratto di lavoro (che modifica il comma 1 dell’art. 53 del CCNL del 2007) . In esso si dice che il personale ATA “partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all’elaborazione del Pei in base all’articolo 7, comma 2, lettera a) del Dlgs 66/2017”.
Diventano per il personale amministrativo dunque ora non più “aggiuntive”ma obbligatorie, tra le mansioni da svolgere, con rilievo e specificazione contrattuale, alcune attività e gli si assegna un ruolo partecipativo finanche nell’elaborazione del PEI, come previsto appunto dal citato articolo 7 del DLgs 66/2017, in cui si legge che “che il PEI è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità, nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare”. E le figure professionali specifiche interne alla scuola sono appunto da ricercare anche in coloro tra il personale ATA che si occupano, per qualunque aspetto, degli alunni e degli studenti con disabilità.
La sottolineatura del coinvolgimento del personale scolastico non docente nella progettazione didattica e nella promozione dei processi d’inclusione è resa più chiara col suo possibile ingresso anche decisionale nel GLO, nell’elaborazione del PEI (vedi qui). Tutte le componenti del personale scolastico sono dunque ora chiamate ad agire e il ruolo che esse assumono, adesso con maggiore specificità e consapevolezza, nel processo d’inclusione degli alunni con disabilità è il maggior banco di prova per la scuola intesa come “comunità educante”.
Entriamo dunque nei dettagli di questi cambiamenti per il personale ATA e per la scuola.
Per favorire l’inclusione degli alunni con disabilità lo Stato (attraverso Il MIUR e gli enti locali) mette in atto varie misure di accompagnamento, quali: finanziamenti di progetti e attività per l’integrazione; assegnazione di fondi per l’acquisto di materiali e ausili; iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare, nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare; il supporto d’insegnanti di sostegno; l’attivazione di prestazioni assistenziali con gli assistenti alla comunicazione, gli assistenti all’autonomia e gli assistenti all’igiene; il trasporto gratuito.
Il personale tecnico e amministrativo ha in tutto questo un ruolo intenso e peculiare nella gestione di pratiche, contabilità, rapporti con enti esterni alla scuola, sussidi e ausili didattici, attrezzature tecniche e tecnologie assistive, ecc. Ruolo che richiede nuove e variegate competenze e quindi apposita formazione.
Più precisamente codificato è il ruolo dei collaboratori scolastici (anche se, come diremo nel successivo post, non mancano in proposito querelle interpretative). Vediamo dunque quali sono i loro specifici compiti nella gestione della disabilità.
Ai collaboratori scolastici è espressamente affidata la cosiddetta assistenza materiale e di base degli alunni con disabilità. Con questa generica indicazione in realtà s’intende l’ausilio fisico agli alunni con disabilità all’interno della scuola, dall’accompagnamento all’ingresso e all’uscita della scuola allo spostamento all’interno di essa, dalle attività di cura della persona all’uso dei servizi igienici e all’igiene personale. Questi ultimi aspetti sono espressamente ribaditi dall’articolo 3 del D. Lgs 66/17 (“il collaboratore scolastico si dovrà occupare personalmente dell’assistenza di base igienico-personale degli alunni disabili e per questo dovrà partecipare a dei corsi di formazione generale previsti dal piano nazionale”) e hanno suscitato un vivace dibattito nella categoria (e non solo) sulla forma e sulla legittimità dell’intervento richiesto. Ciò che è sicuro in questa questione è che, nonostante anche la Legge 107/15 e il D.Lgs 66/17 (dopo le diverse enunciazioni contrattuali e normative precedenti) prevedano corsi di formazione obbligatori sull’assistenza igienica di base per il personale ATA, però non si curano di specificare nel dettaglio né le modalità di svolgimento né il numero di ore di tali iniziative formative.
Considerando poi che tale genere di assistenza è in alcuni casi particolarmente problematico, sia per la specificità della disabilità e quindi della prestazione che richiede sia perché per degli alunni con particolare disabilità vi è la necessità di impegno assistenziale pressoché continuo, da più parti si ritiene che difficilmente possa essere affidata a personale già oberato da diverse altre mansioni; occorrerebbe invece una figura assistenziale ad hoc, specificatamente formata sui bisogni assistenziali dell’alunno o degli alunni di cui si dovrebbe occupare.
In ogni caso, dall’accoglienza agli spostamenti alla cura dell’igiene personale, si affidano ai collaboratori scolastici compiti fondamentali per l’autonomia e il benessere della persona che non possono essere slegati dall’insieme complessivo di cui il PEI si occupa.
Dunque, tutti questi rappresentano significativi cambiamenti nella partecipazione del personale scolastico non docente al processo d’inclusione, frutto sicuramente di una più matura ed efficace gestione scolastica della disabilità: la presa in carico dell’alunno o dello studente con disabilità deve consapevolmente riguardare ora tutta la comunità scolastica, che deve nei suoi confronti agire con interventi di tipo sistemico, in cui ognuno – dirigente, insegnante, tecnico, amministrativo o collaboratore scolastico – è chiamato ad interagire con il proprio ruolo alla progettualità e allo sviluppo didattico ed educativo. Certo permangono ancora ombre, dalla formazione non ben avviata ad una più specifica definizione dei ruoli. Ma che una parte del personale della scuola possa essere non più relegata ai soli compiti burocratici o materiali, ma possa anch’essa divenire parte con piena coscienza e legittimità attiva della crescita e del benessere degli allievi è un passaggio positivo, che diviene ancor più importante nel processo didattico che riguarda gli alunni e gli studenti con disabilità per i quali sono necessari particolari accorgimenti organizzativi e strutturali e atteggiamenti culturali ed educativi che coinvolgono tutto il personale. D’altra parte i processi inclusivi sono, per loro natura, totalizzanti, si riferiscono alla globalità della sfera organizzativa, sociale, educativa e culturale della comunità scolastica. Per poter garantire ad ognuno le condizioni per raggiungere il massimo possibile della realizzazione di sé, agiscono innanzitutto sul contesto e dunque richiedono la condivisione e la partecipazione di tutti.
sd